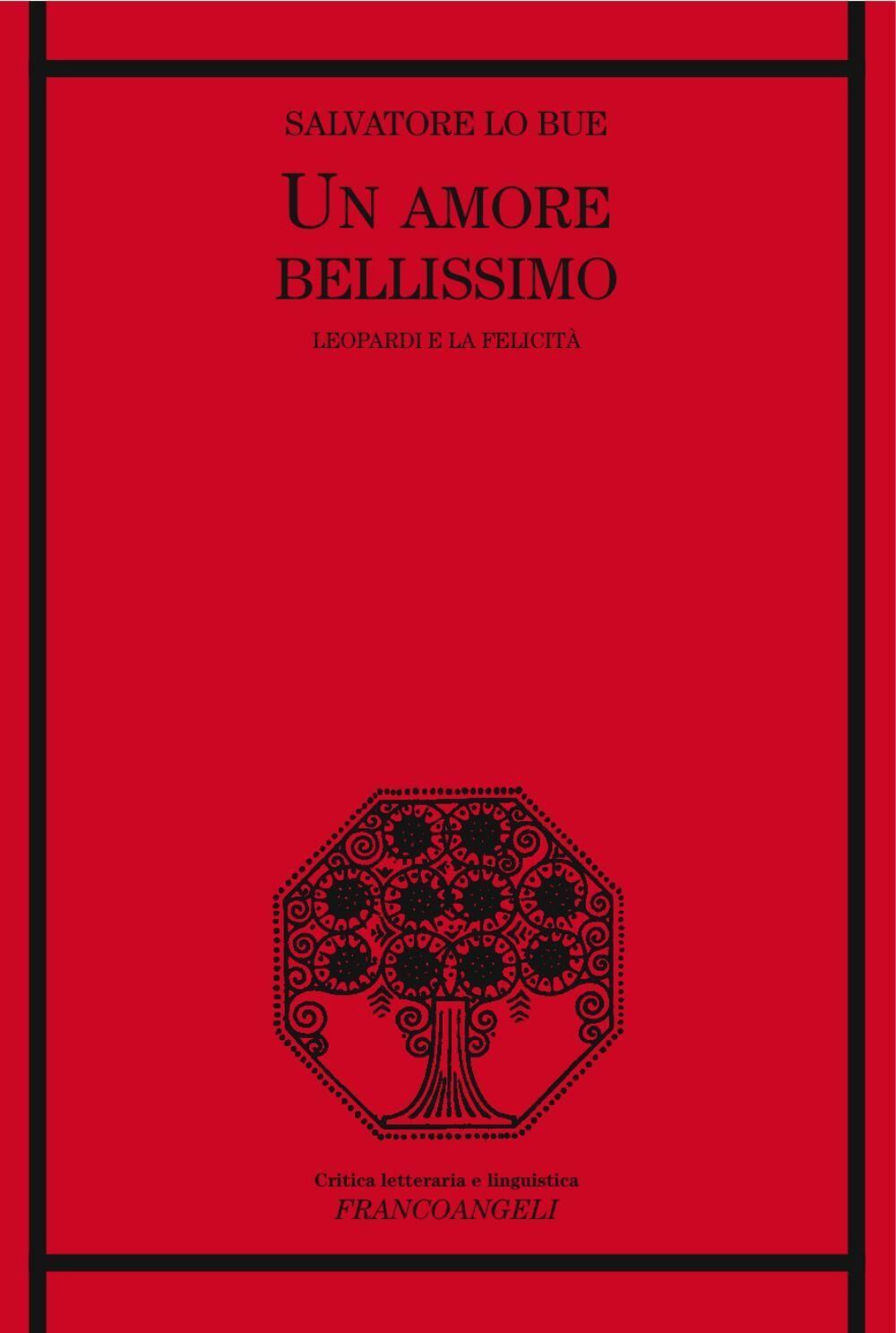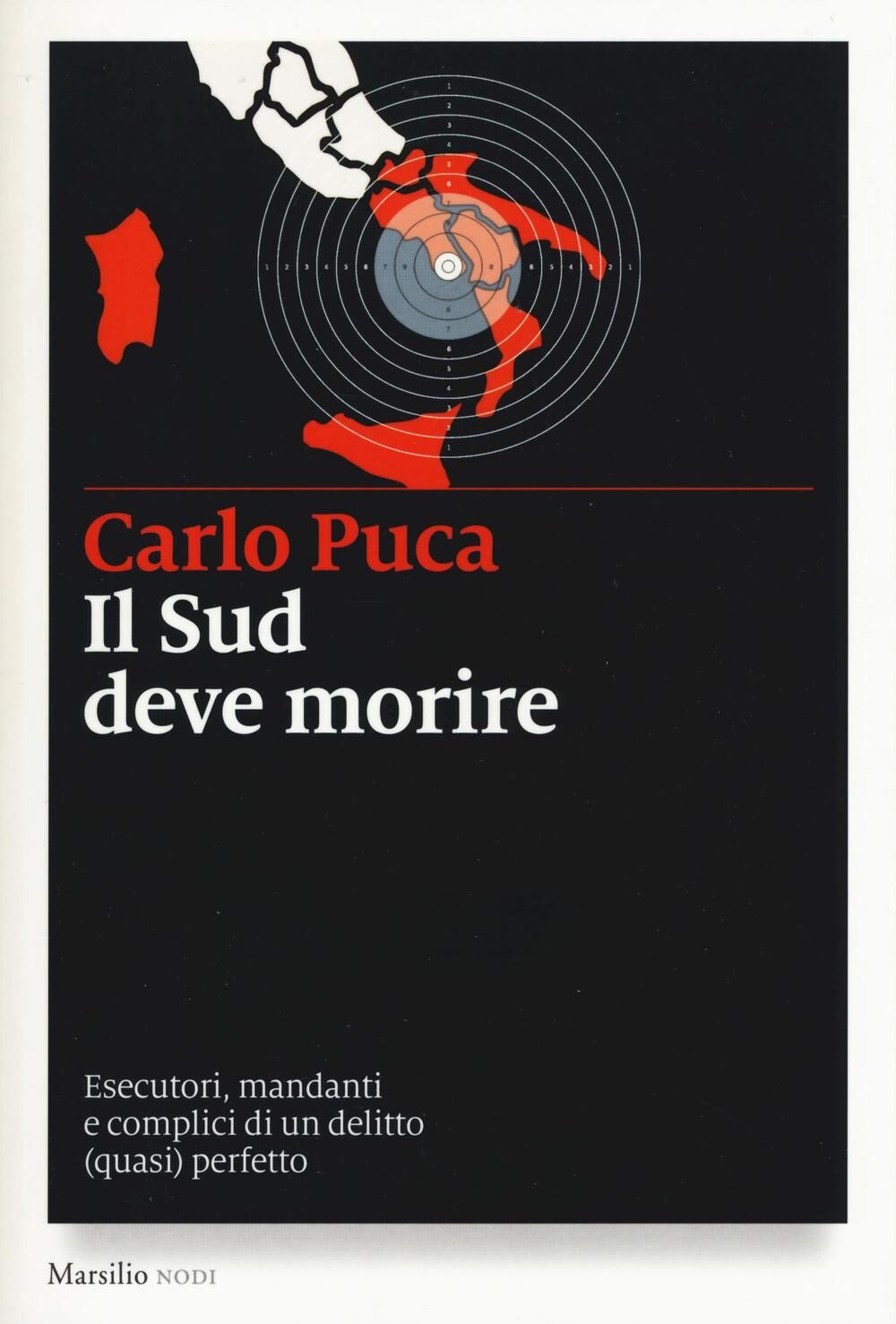di Antonino Sole
Una breve premessa: come critico
letterario e non studioso di estetica, se avessi voluto affrontare l’argomento
svolto in questo volume da Salvatore Lo Bue, l’avrei fatto con gli strumenti
del mio mestiere, altri da quelli di indole filosofica – a non dire delle doti
dialettiche e del fine gusto del bello - su cui si fonda l’esegesi dell’amico e
collega Lo Bue. Pertanto mi si scusi se quanto qui sto per esporre sarà
inadeguato rispetto alle sollecitazioni ricevute da questo volume.
L’ampio saggio dello studioso
coglie uno dei gangli vitali del sentire leopardiano, anzi, non è esagerato
dire, il più vitale: l’amore. Il sottotitolo ( Leopardi e la felicità )
chiarisce esattamente il titolo ( Un
amore bellissimo ): i due termini,
infatti, sono in Leopardi strettamente connessi: se la felicità è per Leopardi
ciò a cui l’uomo veramente aspira, l’amore è il sentimento per eccellenza
attraverso cui gli è concesso di cogliere la felicità. Un punto credo sia
importante chiarire: Lo Bue non intitola
il saggio, ad esempio, “ Gli amori di Leopardi “, ma Un
amore bellissimo . Benché nello
svolgimento del suo tema egli accenni a vari momenti di Leopardi innamorato e
alle diverse creature femminili che suscitarono in lui il sentimento
dell’amore, ciò che davvero conta per lo studioso è la natura di questo
sentimento, quanti e quali altri sentimenti la sua presenza suscita nel suo
cuore; sentimenti molteplici, indefiniti, contraddittori ( o in apparenza contraddittori,
ad esempio quello della morte che talora si accompagna a quello amoroso ),
tutti però indici di vita, di vitalità, di cui il culmine, difficile ma non
impossibile da attingere, è per Leopardi la felicità che dona l’amore. Da
quanto ho adesso osservato dipende il fatto che le poesie d’amore analizzate
dallo studioso non si dispongono in ordine cronologico ( tranne la prima e
l’ultima ), ma formano una sorta di discorso continuo il cui filo è suggerito
dalla complessità di un sentimento, l’amore, di cui le singole tessere formano
l’unità del mosaico. Non stupisce, perciò, per fare qualche esempio, che Amore e morte sia analizzata prima di A
Silvia, o che Alla sua donna sia preposto Il Risorgimento. Ma, che cosa nasce da Amore, denotato
spesso come Iddio da Lo Bue? Da un lato, quando è vissuto, intensamente, al
presente, felicità; dall’altro, quando esso è un ricordo, una rimembranza,
quando l’oggetto dell’amore, un tempo idoleggiato, non c’è più, accoramento e
insieme intenerimento, da cui alta si leva la poesia.
Io credo che le pagine dedicate
al problema della genesi della vera poesia siano tra le più dense del saggio;
ma, devo ammettere che questo tema, il quale viene svolto con ampi riferimenti
a poeti e poetiche dell’Ottocento e del Novecento europeo, è quello sul quale,
per scarsa competenza, ho assai poco da osservare, se non che esso, mi pare, si
lega a quello sulla essenza della vera poesia, la quale esiste nell’animo del
poeta ancora prima di prendere forma sulla pagina e che, dirà più avanti Lo Bue
( ma è parte dello stesso discorso ) più della filosofia è enigmatica,
refrattaria a farsi rinchiudere in uno schema, come la vita; sicché poesia e
vita hanno una stessa radice. Ora tutto questo ( da me riassunto alla meglio )
è ben detto e ben argomentato; tuttavia un punto mi lascia dubbioso, ossia la
lettura in chiave romantica del rapporto Leopardi/ Platone sulla “ teoria
dell’amore “. Così si esprime a questo proposito lo studioso proprio all’inizio
del suo libro : “ La teoria dell’amore
di Leopardi si pone come la più profonda e radicale rilettura romantica della
teoria platonica dell’amore “. Il dubbio nasce in me dal fatto che Leopardi non
si definì mai romantico e fra i critici non tutti , com’è noto, lo ascrivono
alla schiera dei romantici. A ciò si aggiunga che Platone non fu, in quanto
filosofo, particolarmente congeniale a Leopardi, il quale, sotto questo
aspetto, lo cita con pieno assenso ma di passaggio ( Zib.3444 ) solo a proposito di un passo del Convito in cui, per bocca
di Aristofane, il filosofo dell’Accademia parla del “ desiderio perpetuo “
acceso dall’amore nell’amante; desiderio che potrebbe soddisfarsi solo se
amante e amata diventassero “ una cosa sola”. Ma, se non sbaglio, questo
pensiero di Platone coglie un aspetto particolare dell’Amore, non la sua natura
di essere intermedio tra i due mondi che, come tale, crea bellezza. Lo Bue,
naturalmente, non fa di Leopardi un platonico tout court : egli
distingue la visione materialistica della vita di Leopardi, da quella dualistico-spiritualistica di
Platone, ma, in fin dei conti, per ciò che riguarda l’amore le due concezioni,
a suo parere, non si differenziano molto, se la forza creatrice del dèmone
Amore, per il filosofo greco, genera la bellezza sia del corpo, sia dell’anima,
così come in Leopardi bellezza è quella partorita da un Amore che ha radice
altresì nell’anima, ma legata, non separata dal corpo. Il segno di questa
interpretazione della poesia leopardiana ( e non solo di quella d’amore ) si
coglie in tutto il volume dall’accento posto da Lo Bue sulla triade
Amore/Bellezza/Poesia e sull’eternità degli ultimi due termini (
Bellezza/Poesia ). Ma, si sia o no d’accordo su questa chiave di lettura, è
altro, ossia l’individuazione di qualcosa di più intimo e forte nell’animus leopardiano, il nucleo più fecondo e persuasivo dell’interpretazione
di Lo Bue. Prendendo le mosse dal sentimento d’amore del poeta, ma non
limitandosi ad esso – come vedremo – lo studioso mette in piena luce l’aspetto
attivo, anelante alla vita e alle forti emozioni del mondo interiore del poeta
di Recanati, senza porre in ombra ( tutt’altro ) il lato negativo, tendente al
tedio, alla solitudine, all’abbandono, all’absence ( dirà in una
lettera al Viesseux ), che trova il suo definitivo fondamento speculativo nella
concezione della natura matrigna, che tutte le creature destina al dolore e al
nulla. E’ da questo sfondo negativo, già intuito prima dell’Islandese – si pensi all’ Ultimo
canto di Saffo, su cui si sofferma
Lo Bue – che più netto si staglia l’anelito alla vita vera, ai palpiti del
cuore, alla felicità. Ciò viene messo in luce dalla lettura sensibilissima del
ciclo di canti per Aspasia, dove il
poeta afferma con convinzione che l’amore, quando è forte passione, può se non
proprio vincere, almeno porre in oblio il “ vero “ ( cioè la negatività del vivere ), e che la
felicità è possibile su questa terra. Ho detto che l’analisi che Lo Bue fa di
questi canti ne pone in piena luce la grande forza emotiva e poetica, ma mi
preme di aggiungere che la sua anima ‘ romantica ‘ rende piena ragione alla
poesia del più patetico fra i canti del ciclo di Aspasia, Consalvo, un canto spesso svalutato dalla critica. Non meno fine e attenta nel
rilevarne la ricca trama sentimentale è l’analisi di due dei canti più perfetti
di Leopardi, A Silvia e Le ricordanze, dove il
rinato cuore del poeta, cantato con incredula meraviglia ne Il risorgimento, è il fertile terreno da cui sorgono le memorie, care e acerbe a un
tempo, della prima giovinezza e dei primi amori del poeta per due fanciulle,
Silvia e Nerina; creature fiduciose nell’avvenire, presto smentito dalla sorte
funesta, verso le quali si fa sublime il canto di intenerimento pietoso del
poeta. Ma la tenerezza e la pietà riguardano lo stesso poeta, che ricorda il sé
stesso di allora e lo raffronta a quello attuale, disilluso, sì, ma che si
commuove a pensare, anzi a rivivere nel ricordo, quella stagione della vita in
cui per poco idoleggiò l’amore, per poco nutrì questo dolce sogno. Ho cercato
in queste poche righe di dare appena un sentore della ben altra analisi che di
questi due capolavori della poesia leopardiana fa Lo Bue, il quale, tuttavia,
tra i due giudica più compiuto A Silvia, per felicità di
invenzione oltre che per delicatezza e complessità di moti sentimentali.
Come ho accennato all’inizio il saggio di Lo Bue ha il suo centro nel
sentimento d’amore di Leopardi, espresso in vari modi, ma nella sua essenza
uno; ossia forza che suscita nell’animo un tumulto di passioni che vivifica e
persuade chi ama che la vita è degna di essere vissuta. Ma il discorso di Lo
Bue ha una portata più ampia: un paragrafo, infatti, viene dedicato a L’infinito
e l’ultimo capitolo alla Ginestra. Più ampia non significa però che i
due canti ora citati siano staccati dal tema principale, bensì che il
sentimento dell’amore di Leopardi si esplica anche in poesie come L’Infinito,
che in apparenza sembra non avere a che fare con l’amore. Quanto poi alla Ginestra,
il nesso con il tema dell’amore è ancora più stringente. Perché l’Infinito
in un discorso sull’amore? Intanto, nota Lo Bue, perché esso è il risultato
perfetto di quella conoscenza dei moti interiori traslati in poesia
sperimentata nelle Memorie del primo amore e poi nella lirica Il
primo amore, e poi, se colgo bene il suo pensiero, la consapevolezza del
bello poetico attinto in questo breve ma amplissimo canto è il segno della
profondità e delicatezza del proprio animo, quale egli esperì ( e continuerà a
esperire ) da innamorato. Aggiungerei, da parte mia, che c’è un verso nei Nuovi
credenti in cui accusando di opportunismo politico alcuni letterati
napoletani, dice che il “ cor “ di costoro, “ Né il bel sognò giammai, né
l’infinito “: infinito e bello sono quasi sinonimi, ma quanto leopardiano anche
quel “ sognò “ !
Più lunga, ma chiara è la via che da Leopardi poeta d’amore conduce alla Ginestra.
Due sono i sentieri che convergono in questa via: l’uno è la riflessione di
Leopardi sul sentimento della compassione, l’unico, in certe circostanze,
puramente altruistico. L’altro sentiero muove dalla memorabile pagina del Dialogo
di Plotino e di Porfirio, in cui il maestro prega l’allievo, tentato
dall’idea del suicidio, di deporre questo proposito contrario all’affetto che
ci deve legare alle persone care, cui quest’atto estremo procurerebbe dolore (
e qui, mi pare, Plotino/Leopardi ritorna sul tema della compassione ). Ma il maestro non si
limita a deprecare quest’atto in quanto sommamente egoistico; egli indica
all’allievo come curare questa inclinazione barbara e illiberale: la cura consiste
nel farsi coraggio insieme, nel confortarsi insieme dei molti mali che la vita
riserba a tutti, nel “ tenersi compagnia l’un l’altro “; espressione che
richiama “ l’amante compagnia “ della Ginestra. Come si vede l’amore non
è caduto per sempre dopo la dolorosa esperienza di Aspasia, di cui è
straziante documento A se stesso: esso ha assunto un’altra forma, più
ampia, in certo modo più pura, quella della solidarietà tra gli amici, ( tra
tutti gli uomini nella Ginestra ) che nella sua essenza è amore; parola che ricorre più volte
nell’ultimo dei canti leopardiani. E’ in forza di questo nobile sentimento che
Leopardi continua a dire sì alla vita, pur senza rinnegare il suo “vero”, ossia
il male insito nell’esistenza.
Al di là del messaggio sociale
dirompente, con assoluta persuasione rivolto all’intera umanità, ossia l’unione
di tutti gli uomini contro il comune nemico, la natura matrigna, ciò che più
conta, credo, nell’economia del discorso di Lo Bue è l’accento posto sulla
vitalità dell’animo leopardiano, fondata sul sentimento dell’amore, scoperto la
prima volta nel ’17 e che, covando sotto la cenere dei momenti più abbandonati
e freddi dell’ animo suo, rinasce costantemente e perdura fino alla fine della
sua vita. La Ginestra è indubbiamente il più complesso dei canti
e, al suo solito, lo studioso ne fa sentire la grandiosità, che ha il suo
nucleo generativo nella lotta impari tra lo “ sterminator Vesevo“,
oggettivazione visibile della forza distruttiva della natura, e la fragilità
dell’uomo e delle sue opere ( sono evocate Pompei ed Ercolano distrutte
dall’eruzione del 79 d. C. ). Su questo sfondo fosco e arido, il solo fiore che
umanizza il deserto è la ginestra, che tenacemente e pericolosamente vive
abbarbicata sull’ “ arida schiena “ dell’ “altero monte “. Il fiore della
ginestra, il cui profumo “ i deserti consola “, è simbolo della Poesia, “ voce
del sommo Iddio che è Amore “ e, al tempo stesso, dell’ atteggiamento dell’uomo
dignitoso, conscio del suo doloroso destino, ma senza “ venire a patti” con esso ( come Leopardi aveva detto nel Dialogo di Tristano e di un amico ). Con queste notazioni ( da me
schematizzate ) si chiude circolarmente il discorso dello studioso, il quale
giustamente, come già accennato, vede nel sentimento d’amore, e nella poesia da
esso generata, il nucleo più vivo dell’animo leopardiano. Sentimento d’amore e
della poesia scaturita dall’attrito di esso con l’ “acerbo vero “, che rende il
poeta conscio della propria nobiltà; quella nobiltà in nome della quale egli,
come la ginestra, affronterà la morte con coraggio.
Mi avvio alla conclusione. Credo
sia importante notare che nel suo discorso su Leopardi poeta d’amore, in senso
stretto e in quello più ampio ( Plotino
e Porfirio e La ginestra ), Lo Bue ha ridotto al minimo i riferimenti alla biografia del poeta;
ciò che conta per lui è la storia dell’anima leopardiana. Di questa “ storia di
un’anima “ ( per dirlo col titolo di un romanzo autobiografico ideato dal
giovane Leopardi ) Amore, con la
maiuscola, è l’agente principale e ininterrotto dall’adolescenza alla fine
della sua vita. Un’altra cosa voglio dire: l’impalcatura generale e l’analisi
dei canti di cui abbiamo fatto parola sono frutto di riflessione personale,
starei per dire, di un corpo a corpo con i testi del poeta recanatese: poche le
citazioni di altri studiosi; ma copiosi i rimandi allo Zibaldone, meno all’epistolario ( e se ne intende il motivo, per ciò che abbiamo
osservato sulla quasi nulla attenzione alla biografia ) congrui alla linea
della sua indagine quelli alle Operette
morali: importante, su
quest’ultima opera, la citazione della parte conclusiva della Storia del genere umano, in cui Leopardi parla di Amore figlio di
Venere celeste.
Altro ci sarebbe da illustrare
del libro di Lo Bue, soprattutto sulle numerose pagine che vanno sotto il
titolo, “ Lo sguardo Di Orfeo “, ma lì, essendo il tema squisitamente estetico,
mi muoverei con una certa difficoltà, per ciò me ne astengo. A parer mio – e
chiudo – il libro di Lo Bue, oltre che indagine approfondita sul sentimento
d’amore in Leopardi e sulla poesia nata e nutrita da questo sentimento, risulta, a parer mio,
una interpretazione complessiva della sua vita interiore e della sua poesia.
Ciò gli accade meglio, o mi sbaglio, quando egli dimentica il suo schema
interpretativo platonico-romantico ( che pure affiora qua e là ), e, guidato
dalla sua sapiente e sensibile lettura dei testi, attinge le più profonde
radici di Leopardi, uomo e poeta sommo. A parer mio, il libro di Lo Bue apporta
nuova luce all’intelligenza della poesia leopardiana, tanto chiara in
apparenza, quanto complessa, enigmatica, come la vita, nelle sue intime
sorgenti.