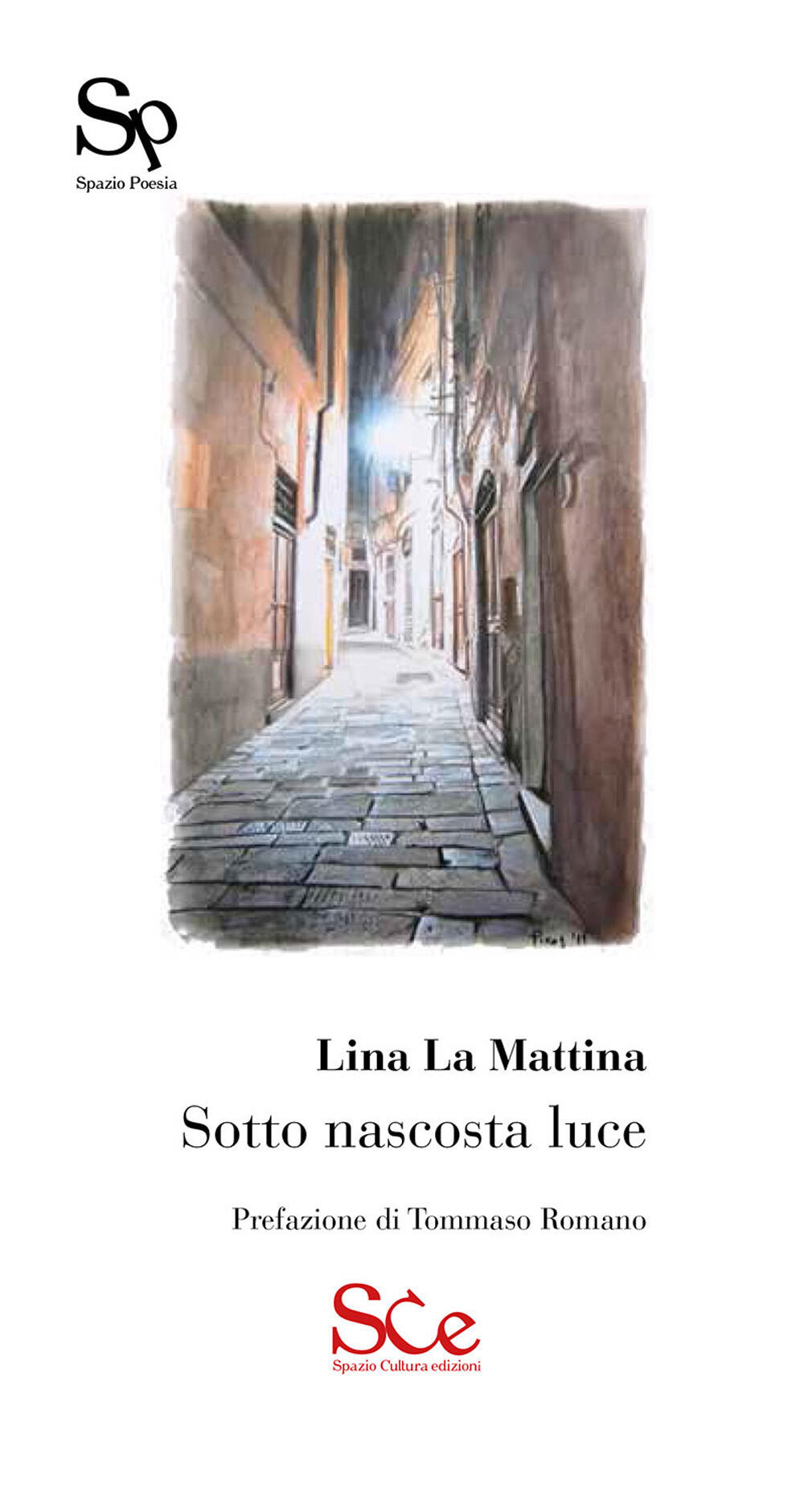di Domenico Bonvegna
Ormai esiste una
discreta letteratura sulla conquista del Sud, nel 1860 da parte degli eserciti
del Regno di Sardegna. Si potrebbe elencare diverse opere più o meno complete
sull'argomento. Per quanto mi riguarda il primo testo che ho letto è quello di Carlo
Alianello, “La Conquista del Sud”. Recentemente è stato
ripubblicato in versione Pickwick, della Piemme, il libro di Pino
Aprile, “Carnefici”. Qui il giornalista e scrittore
pugliese, porta a compimento l'inchiesta iniziata con il suo precedente libro “Terroni”.
Ha lavorato cinque anni Aprile per arrivare alla tesi che al Sud, gli eserciti
piemontesi dei Savoia hanno compiuto un vero e proprio “genocidio”.
Centinaia e migliaia di persone scomparse o costrette a subire la deportazione.
Rastrellamenti, marce forzate, torture e fucilazioni dei cosiddetti “briganti”,
uomini armati, che si sono ribellati al nuovo ordine imposto da Torino.
Aprile ha
ricostruito pazientemente con un'incalzante e drammatica ricerca, una mappa di
un immenso “Arcipelago gulag”, fatto di una serie di numeri, di
dati, di confronti e incroci sulla popolazione meridionale. Praticamente ha
pubblicato fonti e documenti, ritrovati nei vari libri consultati, ma anche in
archivi, che per troppo tempo sono stati occultati dalla storiografia
ufficiale. Il giornalista pugliese oltre a fare riferimento ai tanti storici
locali, si appoggia ai vari De Sivo, Molfese, Pedio, Alianello, Zitara, Di
Fiore.“Sono ormai decine gli specialisti e i volontari che sventrano archivi
ignorati in Italia e all'estero, per trarne e divulgare decine di migliaia
(avete letto bene: decine di migliaia) di schede, verbali, rapporti, documenti,
promemoria che quasi nessuno ha cercato in un secolo e mezzo. E' la somma di
quelle carte che conduce alla parola genocidio”.
Chiaramente
Aprile, è stato contestato dai vari pasdaram risorgimentisti, mettendo in
discussione i suoi dati numerici, hanno cercato di ridicolizzarlo, bollandolo
come superficiale e dilettante. Lui stesso è consapevole di non aver raggiunto
la scientificità delle sue tesi e lo scrive più volte nel suo testo. E infatti,
rinvia ad altri possibili studi demografici al fine di comprendere meglio la
portata del massacro di quel periodo, delle popolazioni meridionali. Tuttavia
credo che Aprile, nonostante non sia stato in grado di produrre dati numerici
esatti sui morti, sia riuscito a far passare la tesi che al Sud i cosiddetti
“liberatori” piemontesi hanno compiuto un genocidio. Peraltro Aprile non teme
di esagerare utilizzando nel suo libro termini abbastanza forti per descrivere
l'aggressione piemontese, come deportazione, spopolamento, occupazione
militare, invasione, colonizzazione, pulizia etnica, domicilio coatto.
Termini a cui ci aveva abituato il secolo scorso, il terribile Novecento,
il secolo delle “idee assassine”.
Tuttavia i
meriti di Aprile, potrebbero essere anche altri, come ad esempio quello di
rendere più giornalistico il tema della cosiddetta conquista e unificazione del
nuovo Regno d'Italia. Carnefici, rappresenta una buona summa dei dieci
anni di guerra che si sono svolti nelle province meridionali, oltre che essere
un buon manuale per il meridionalismo più o meno nostalgico del borbonismo,
anche se non monarchico. Però non è condivisibile quell'astio, quel furore
sotteso di Aprile nei confronti della Lega. E' strano che uno
come lui abituato ad andare controcorrente, non riesca a comprendere che la
Lega, soprattutto quella recente di Salvini (nonostante le sue confusioni)
potrebbe essere una alleata del Sud, contro il centralismo statalista romano
che danneggia tutti gli italiani. I nemici del Meridione bisogna andarli a
cercare altrove caro Aprile.
Il testo di
Aprile consiste di quattordici capitoli in 464 pagine molto dense di nomi, di
fatti e avvenimenti coinvolgenti.“E' duro il viaggio che vi propongo di
rifare in queste pagine; - scrive Aprile - ho cercato di renderlo
agevole, perchè ci muoveremo in un'Italia molto diversa da quella che ci è
stata raccontata”. L'autore ci avverte che volutamente ricorre alle
ripetizioni in forme diverse, proprio per cercare di farsi capire da tutti, per
non escludere nessuno. Tutti devono sapere e rendersi conto di quello che hanno
fatto al Sud. Infatti il testo è facile, comprensibile, sostanzialmente una
specie di bignami divulgativo sui crimini commessi nella guerra del Sud.
Cominciamo dal
costo umano sofferto dai meridionali a causa della guerra di aggressione
scatenata dai savoiardi. Lo storico Christopher Duggan, in “La forza del
destino. Storia d'Italia dal 1796 a oggi”, pur mancando di dati recenti,
ritiene che i morti sono oltre 150.000. Mentre per la Civiltà Cattolica,
la rivista dei Gesuiti di allora, sono addirittura oltre un milione. Mentre
Aprile si ferma al numero forse più ragionevole di 110.000,120 mila.
“Erano
essere umani; stavano a casa loro. E questo divenne il loro delitto”. Oltre ai cosiddetti
“briganti” che presero le armi, furono condannate le mogli, “come
manutengole con complicità di primo grado. Fanciulle di 12 anni, figlie di
briganti, avevano subito condanne di 10 o 15 anni”, scrive Franco Molfese,
che ritrovò nella biblioteca della camera dei deputati, resti della relazione
Massari sull'opposizione armata al Sud, spacciata per criminalità.
Intanto con il
procedere delle ricerche,“si è scoperto che il numero dei deportati civili
al Nord fu incredibilmente maggiore di quanto si sapeva, e ancora si trovano
insospettati archivi da cui emergono, a migliaia, le tracce di vite distrutte”.
Peraltro da questi conti è esclusa la Sicilia, perchè era scandaloso ammettere
che l'isola, la culla della rivoluzione, si ribellasse al regno sabaudo. Ancora
oggi si ripete che in Sicilia è esistita solo una banda di briganti, invece non
è così. Basta solo la rivolta del “Sette e mezzo” a Palermo nel
1866, ma non solo, tutte le altre città della Sicilia si sono ribellate al
dispotismo piemontese.
E' incredibile,“non
c'è mai stata nelle nostre università, una vera ricerca per sapere quanti
furono i meridionali uccisi o fatti morire nella guerra condotta dall'esercito
sabaudo contro la popolazione civile (quella con l'esercito borbonico, manco
dichiarata, nonostante l'invasione di un Paese ufficialmente amico, finì in
pochi mesi; l'altra, contro i cittadini disarmati, e formazioni sparse di
ribelli, durò almeno dieci anni)”.
Da più di un
secolo e mezzo, scrive Aprile, “gira un balletto di cifre più o meno
attendibili sui 'fucilati' (bastava poco: un sospetto, una calunnia, le mire di
un vicino sui tuoi beni, persino su tua moglie o tua figlia); o sui 'briganti',
abbattuti come tali anche se militari che, con la divisa e le proprie armi,
affrontavano da guerriglieri un invasore; o perchè contadini derubati delle
terre demaniali[...]”.
Poco si è
scritto sulle deportazioni subite dai meridionali. Un garibaldino, un
certo Ferrario, passato nell'esercito sabaudo come bersagliere, tornò in
Calabria e scrisse un diario sui fatti che risalgono al 1868-69. Lo ha trovato
a Novara nel 2015, il professore De Simone, autore di “Atterrite queste
popolazioni”. Il diario si riferisce a Rossano, alle carceri grandissime,
dove richiudevano i manutengoli ed i conniventi dei briganti. Queste persone,
vecchi e lattanti costrette a spostarsi
per 40-50 chilometri, bastonati, senza fermarsi neanche per i bisogni, “venivano
sferzati dai carabinieri e dai soldati di scorta”. Qui il diario dell'ex
garibaldino è molto preciso, e ci fornisce molti dettagli sulle torture subite
da questi poveri cristi. Infatti i carcerieri piemontesi per estorcere
informazioni sui briganti, torturavano a più non posso, comportandosi come dei
veri e propri carnefici. Queste deportazioni assomigliavano molto a quelle
patite all'inizio del novecento dagli Armeni.
Alla fine del
primo capitolo brevemente Aprile racconta i vari passaggi della
disgregazione dell'antico Regno di Francesco II.
Il complotto
anglo-piemontese.“Che non ci fosse 'un piano coordinato' per distruggere il
Regno delle Due Sicilie ormai solo i disonesti possono sostenerlo”. E' notorio che la Gran
Bretagna, come hanno scritto in tanti, ha complottato per abbattere il Regno
Duosiciliano. Sul quale poi si è innestato il piano dei Savoia, “con la
lunga opera di corruzione di ministri e alti ufficiali dell'esercito e della
Marina napoletani; le trame di Cavour con la Francia; gli accordi con la
malavita siciliana, la rete massoniche e liberale allertata per l'insurrezione
e l'appoggio ai garibaldini e all'esercito piemontese; le collette dei massoni
stranieri per amare la spedizione di don Peppino, rimpolpata da migliaia di
'disertori' sabaudi e mercenari di mezzo mondo, e assistiti dalla flotta
britannica [...]”.
L'economia
napoletana venne demolita. Chiuse le grandi fabbriche, rubate e spostate al Nord i
vari macchinari, stessa cosa per l'oro delle banche, requisiti i beni
ecclesiastici che erano parte rilevante del sistema economico. A questo
proposito, Aprile, purtroppo, non cita gli interessanti studi di Angela
Pellicciari sulla guerra del Risorgimento alla Chiesa Cattolica.
Epurazione
nelle scuole. Per quanto riguarda la cultura Aprile ricorda l'epurazione del ministro
della Pubblica Istruzione Francesco De Sanctis, nelle scuole e nelle
università, “per immettervi docenti il cui unico o maggior pregio era la fedeltà ai Savoia (che molti
scoprirono all'istante. E più di sessant'anni dopo, quando Mussolini obbligò i
docenti universitari a giurare fedeltà al Fascismo, solo una quindicina su
1.200 rifiutarono)”. Inoltre i piemontesi chiusero tutti gli istituti
superiori di Napoli, un migliaio di scuole in tutto il Regno, soprattutto
quelle private. Vennero chiuse una trentina di giornali, ecco perché non si è
potuto raccontare la vera storia dell'aggressione e conquista militare del
Regno da parte dei piemontesi. Chi lo ha fatto doveva usare pseudonimi o
pubblicare all'estero.
“Dichiararsi
cittadino del proprio Paese invaso divenne reato punibile con la morte, la
deportazione, il carcere, la perdita dei beni[...]”. Furono rimossi quasi tutti
i vescovi, alcuni esiliati, svuotati e chiusi i conventi, soppressi gli ordini
religiosi (meno quelli dei mendicanti che non avevano nulla da farsi rubare),
sorvegliate le prediche in chiesa e messi sotto vigilanza i fedeli che
frequentavano parrocchie di sacerdoti non filo-piemontesi; avanzata perfino la
pretesa di controllare le confessioni.
Praticamente per
chi non accettò il nuovo corso o divenne sospetto di non accettarlo o persino
di tiepida adesione, la sua vita smise di essere un diritto.
Inoltre il
Piemonte come Stato violò ogni accordo, legge, trattato e persino ogni limite
di decenza e umanità, in nome di un progetto politico-economico. Torino aveva
fortemente bisogno di denaro, il Regno di Sardegna stava fallendo, non avevano
più soldi per pagare i dipendenti pubblici e i soldati. Così ne approfittò di
inglobare il Regno del povero francischiello.
Sostanzialmente
scrive Aprile:“il Piemonte impose se stesso, le sue armi, la sua libertà
chiudendo giornali, riempendo le carceri, deportando e fucilando, impose le sue
tasse, le sue leggi e persino i suoi impiegati e le sue balie negli orfanotrofi
di Napoli, poi disse che gliel'avevano chiesto gli italiani. E quelli che
cercarono di smentire o opporsi fecero una brutta fine”.
Pertanto,
insiste Aprile:“la dimensione del massacro nascosto sotto il mito del
Risorgimento è stata sempre contestata (su come si scrive la storia del nostro
Paese, basti dire che l'Istituto cui fu affidato tale incarico, nel Regno di
Sardegna che poi divenne d'Italia, aveva il compito di impedire la
consultazione dei documenti che potessero offuscare la dinastia sabauda; le
carte scomode potevano essere distrutte, e l'elaborazione dei documenti avuti
in consultazione era sottoposta a doppia censura durante e dopo la stesura dei
testi in cui erano citati)”. Bisogna aspettare il 2014, per intravedere
qualcosa sull'enormità del prezzo pagato dal Sud, in vite umane. Un rapporto
dello Svimez condotto dal dottor Delio Miotti, svela che nel 1867, la
popolazione meridionale diminuì, invece di crescere. Succederà solo altre due
volte, in un secolo e mezzo.
Per il momento
mi fermo, penso di ritornare sul tema.