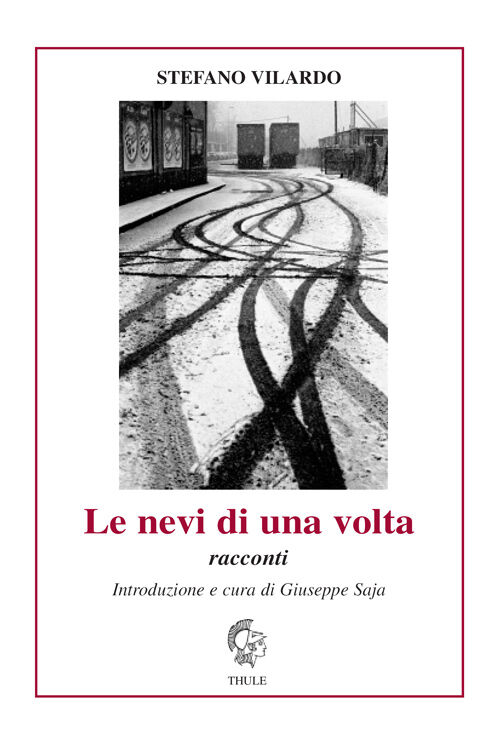di Tommaso Romano
Cannella arriva al terzo libro dopo 12 anni con un’interruzione editoriale anche abbastanza lunga nel tempo. E, tuttavia, tornando a Itaca, e cioè, tornando a Thule; pubblicando proprio il suo terzo libro. Il libro di cui parlerò e di cui già per lacerti abbiamo ascoltato note preziose sia da Vito Mauro che da Aldo Gerbino, che ringrazio naturalmente molto, ma anche dalla bellissima, e direi per molti versi, introduzione all’opera più “artistica” di Cannella illustrata da Vinny Scorsone. Un intervento di rilievo che sottolineo anche per le caratteristiche di ambivalenza e contaminazione che naturalmente con i vari linguaggi Cannella intesse. Un “personaggio” che non la manda a dire. La sua scrittura, come la sua arte, formano infatti un Unicum; non c’è una differenza, sono stati molteplici della sua stessa personalità, dell’essere, di uno spirito libertario che nutre una dimensione di totalità verso l’arte, che diventa arte-vita; anche come scelta esistenziale, ma anche e soprattutto come arte visionaria, nella dimensione più ampia.
Questa creatività diventa fondamentalmente il viaggio individuale nella scrittura, non tanto nell’avvenimento, non certo nei fatti, che pure si incrociano e scontrano in questo libro, che va letto esattamente come una cifra stilistica. Un viaggio che definirei due volte allucinato. Io stesso ho avuto qualche esperienza di scrittura automatica. Qui, per esempio, c’è un autore, lo scrittore Marcello Scurria, a cui ho inteso indicare la scrittura fluviale, un flusso di coscienza, che è anche un flusso creativo irrefrenabile. Ma non irrefrenabile nel senso di anarchicheggiante scrittura, quanto di viaggio allucinato. Allucinato dato che ci sono mille contaminazioni, disseminazioni che, fra l’irrazionale e la ricerca si muovono attraverso quella che io chiamo un’astronave narrativa, che è insieme un’astronave che va verso l’alto ma è anche qualcosa che arriva negli abissi, negli Oceani, in diretta relazione col personaggio che noi spesso non consideriamo ma che è parte pure della nostra avventura ed esperienza. Nella dimensione cosmica dove infatti c’è tutto. Noi abbiamo la terra dove camminiamo, ma in realtà siamo figli del cosmo, del vento, ma siamo anche i figli dell’acqua, di quel divenire cioè che l’acqua rappresenta perfettamente.
In questa possibile astronave narrativa - lo diceva anche la Scorsone rispetto a quelle contaminazioni di cui tutti siamo fortunatamente figli - non esiste una scrittura indipendente, non esiste una scrittura “originale” che non ha padri; una scrittura senza padri non è una scrittura. Una scrittura senza padri, cioè senza maestri, senza punti di riferimento, senza tensioni liriche, senza tensioni esistenziali, senza snodi culturali è una scrittura amorfa, senza riferimenti. La cultura non è altro che ciò che diceva in modo esemplare Aldo Gerbino, cioè quelle contaminazioni necessarie che poi formano l’opera d’arte. Naturalmente è stato citato Pasolini e concordo, ma ci sono tanti altri riferimenti per me (non lo so fino a che punto può valere per Cannella, ha poca importanza) perché il lettore è autonomo rispetto all’autore, il lettore deve sempre e comunque valutare un’opera per quella che è, non per quello che l’autore ha voluto che fosse. E quindi io ci trovo Gadda, Marinetti, anche Antonio Pizzuto, lo straordinario autore di “Signorina Rosina”, “Si riparano bambole”, certo, ci trovo Calvino, ci trovo Borges, cioè tutto quel mondo che poi attraverso anche le citazioni colte, che non sono mai a caso, sono sempre volute, un Introibo all’opera stessa, alla scrittura, a questa scrittura automatica ma necessitante, che entra nelle viscere tormentate dell’umanità.
Fra realtà e finzione, fra ombra e sottosuolo, specialmente nella prima parte. Un sussulto poematico molto complesso, molto affastellato ma necessariamente guidato da quel flusso a cui facevo riferimento prima.
Quindi, tra realtà e finzione ci sono le ombre, quelle del sottosuolo, quelle visioni barocche che sembrano fini a se stesse ma che in realtà riprendono un neo-espressionismo che entra in diretta relazione narrante con il ventre umano, con le profondità, a volte con la dimensione propria di una profondità esacerbata. E qui vi è anche la grande capacità, fra inquietudine e a volte inquietante scrittura, una capacità di maestria narrativa che - io lo so, perché l’ho seguito sempre, anche in quest’opera dove vi sono i rimandi, i ripensamenti - fortunatamente si compiono in opera dell’artigiano della parola… Quindi al flusso è necessario sempre accompagnare la capacità di visionarietà del testo - e tuttavia sempre in relazione con quella scrittura che diventa poi un autentico motivo di vita. E quindi, in questa maestrìa creativa, scorgiamo il nero profondo - anche nel testo una pagina interamente al nero - Opera al nero, tanto per citare; accompagnati da sprazzi immediati che arrivano alla coscienza di un rosso che io definirei pompeiano. Perché ci sono questi straordinari, stridenti contrasti? Come non tornare a Borges, all’Elogio dell’ombra, a quella percezione, presagio esatto del nichilismo. Perché questo è un testo che rifà una storia nichilistica, non la Sua storia, ma una storia… Non è, comunque, una biografia, né un’autobiografia, è una narrazione nichilistica dove cioè si giunge al punto zero, attraversato per intero, dove sentiamo pulsante il combattimento corpo a corpo, il disfacimento, la dissoluzione voluta, invocata, quasi strutturata, e tuttavia sempre scatenata da una memoria, che è per molti aspetti una memoria “visiva”. C’è la peste chimica, una forma del nichilismo, in questo caso, insieme alla navigazione a vista, all’imprevisto, all’eccesso, alla tabula rasa che tutto ciò provoca…
Tutto sommato, allora, Cannella chi è? E’ lo scrittore che riprende oggi e per molti versi alcuni aspetti peculiari del dandysmo. Il dandy… Chi è il dandy? E’ colui che cerca una perfezione stilistica, inimitabile nella vita, che si mette in contatto diretto con la parola, con la forma, coniugando la scrittura con la realtà, il pensiero con l’azione, anche nel momento in cui il pensiero razionale si dissolve, sembra dissolversi, alla ricerca di altro, che poi magari non è altro che un esito discutibile. Con un sottofondo, pensate un po’ al jazz, quello duro, quello pesante, che mi è risuonato rileggendolo, ora, per la presentazione, con uno spirito diverso, quindi con un altro spirito. Questo jazz duro che ti entra, con le parole di Cannella, e diventa quasi una sorta di rancore; e allora i Demoni di Dostoevskij appaiono nella loro forma, nella loro dimensione, e questi demoni abitano pure a Palermo, parlano talvolta in siciliano, non il siciliano alla Camilleri, ma il siciliano che dialoga strettamente, fortemente col malessere, mal-essere, con la dissoluzione, col sottosuolo di Dostoevskij… Sempre verso quella Itaca dell’inconscio che si ricerca, quell’esodo costruito anche di paranoie, visioni, allucinazioni dovute a stati molteplici compreso quello, appunto, delle droghe. Nel dubbio vagante, tuttavia, non si arriva mai apparentemente all’approdo. Questo “spaccio-controcanto” diventa uno “spaccio” della vita, che si prende sul serio nella deriva e non riesce a dare risposte; e, quindi, il viaggio in sé è, per questa narrazione allucinata, più importante della meta. Non c’è, infatti, una meta, è l’Itaca dell’inconscio, non l’Itaca dell’approdo quieto, è l’Itaca sempre dell’andare oltre, verso questo controcanto della vita. Una ricognizione anche sul confine instabile fra ciò che vive e ciò che muore e ciò che si dìsfa… I personaggi ruotano attorno al Personaggio e insieme formano un teatro, legato a una dimensione particolare e tuttavia emblematica e metaforica in un’ottica più ampia, nel segno della liquidità di Bauman. Personaggio straordinario, che ha compreso perfettamente qual è il problema del nostro tempo: non avere riferimenti - tutto scorre - e in questo scorrere c’è anche non la visione greca dello scorrere, ma la dimensione del fluidificarsi…
La scrittura, allora, che cosa è per Cannella? È la rivalutazione, la possibilità rispetto alla liquidità: si scrive per fare rimanere ciò che passa, ciò che si dissolve, ciò che è liquido, ciò che non possiamo prendere in mano perché qualunque acqua, qualunque liquido non lo possiamo trattenere e non potendolo trattenere… si scrive ciò che diventa anche vita e ciò che muore, perché la vita - ci sono delle pagine poi veramente straordinarie, bellissime sulla morte del padre scritte dall’Artista a tutto tondo, riuscendo a dare prova magistrale di scrittura meditata e molto sofferta, molto partecipata. Tutto ciò che nasce, vive e muore, diventa anche forma di ciò che altrimenti non potrà avere forma. Affetti, superfici anche irritanti - a volte la scrittura di Cannella è irritante, ti provoca, ti mette in discussione, ti fa vedere paesaggi che sembrano, appunto, assolutamente inevasi da animo umano; percorsi soltanto da ombre pure e semplici, da noie… la Noia - uno degli elementi di questo libro è la raffigurazione plastica della noia, dell’incapacità anche di reagire, infatti il “Non saltare giù dal letto prima di mezzogiorno”.
Per darvi la misura di questo cammino irritante, che diventa anche la struttura e quasi una fenditura, dice Lui: “un’innata, caritatevole violenza”… Sì!, quella di Cannella è un’innata, caritatevole violenza! Perché violenza innata? Perché c’è una dimensione innatistica di ulteriorità, di necessità di comunicare; caritatevole perché la scrittura è sempre, comunque, sia nel momento in cui si svolge, sia nel momento in cui la si pubblica (è inutile fare discussioni “Io scrivo per me stesso” sono stupidaggini, si scrive sempre per comunicare) anche se poi non è necessario avere un pubblico, l’importante è pensare che fra oggi e domani o fra mille anni, qualcuno si ritroverà come stiamo facendo questa stasera, con le opere, attraverso la scrittura… e quindi perché violenza? Perché non c’è mediazione in Cannella, non c’è la mediazione del buonismo, questo non è per fortuna un libro buonista; e non farebbe piacere a tanta gente che fa del buonismo soltanto una predica e non una pratica di vita. Semmai importante è la Metanoia, che è una cosa diversa, un cambiamento, un mutamento. Allora questo inabissarsi nei singoli frammenti di Cannella diventa una visione dall’oblò, la visione dall’oblò del disfacimento. Il rischio è naturalmente di sprofondare nel silenzio, nel nulla, nel buio, non solo dei personaggi, ma nel nulla, nel buio delle cose… Ad un certo momento nella Sua narrante foga di cui stiamo parlando - qui non ci sono trame da raccontare, qui c’è lo stile da raccontare – l’approccio a Cannella si distende anche a Monet e Cézanne, oltre Duchamp (va bene, questo lo diamo per scontato) ci sono questi afflati chiamiamoli lirici, incursioni di necessità, modi di essere che vanno dal mito ancestrale all’introspezione da autentico fingitore. Sì!, perché Cannella è un fingitore, come diceva Pessoa. Il poeta è un fingitore. Mai prendere un poeta per la Parola, faremmo un moralismo d’accatto, invece c’è Arte, cioè la capacità di trasformare la parola in arte, che è cosa molto diversa. Quindi Fingitore apparentemente svagato, perché Cannella stesso è apparentemente svagato…
In questo libro c’è anche l’infanzia, con tutti i suoi problemi, i suoi drammi, con tutte le metafore nascoste - reali, con le violenze - colme di concettualizzazioni ironiche di disinganno, quasi emblemi di quell’eroe irritato, ma anche assediato da Fantasmi… L’altro elemento fondamentale che ritrovo è quello della Suburra dei vicoli, la droga, il sesso, il proprio fantasma nel rigore emotivo, stimolante in una sensualità nevrotica, a volte fulminante, ed ecco il suo surrealismo; Cannella è un autentico irregolare tra frasi a volte solenni e turpiloqui, tra Céline, che certamente ha un peso in questo libro - e a mio avviso nell’intera sua dimensione poetica - pensiamo al “Viaggio al termine della notte”, insieme a Bukowski, ma anche Brahms, Rimbaud, Beethoven. Insieme alle Sue intromissioni liriche ci sono le Sue estroflessioni dialettiche, in una disseminazione che scompone la logica dal linguaggio per poi ricomporlo. E’ come se noi avessimo davanti un grande puzzle, provando la voglia di scomporlo, di disseminarlo, e la necessità poi di riportarlo, di ricondurlo a unità… e incontriamo il suo linguaggio che diventa anche graficamente libro, pieno di spazi bianchi perché necessari… perché la grafica di questo libro è un accompagnamento alla scrittura: fatta di pause, di vuoti, di riflessioni; un paesaggio che sembra sintetico anche in quei fotogrammi, a volte spiazzanti, piagati, appunto, nel contrasto.
E’ un racconto che mi ha portato anche a Camus, all’Assurdo di Camus, ma mi ha portato anche a rivedere il film, che Lui cita, di Marco Ferreri “La grande abbuffata”. Vedete quanti grandi dicotomie presenti nel libro. La centralità della situazione è un altro elemento fondamentale, non facile da cogliere, perché spesso si rischia di cadere nella narrazione didascalica. Ma non è il caso di Cannella, perché la Sua parola è del sogna-autore, non colui che sogna banalità romantiche, ma dove sogno e autore si mischiano e si uniscono in quelle contaminazioni emotive che fanno da re-flettore, non da ri-flettore… Anche la Sicilia, Palermo, sono presenti esplicitamente, come parti integranti nel discorso di Cannella - perfino con determinate citazioni yiddish - che non sono buttate lì a caso, ma hanno una valenza precisa. In tutto questo labirinto, ci sono gli incroci, c’è la perdita del senso e il tentativo di ritrovarlo; e il libro diventa così un inventario provvisorio: i negati incanti, come dice testualmente Cannella… La reclusione, da che cosa? Nella casa o in una casa di reclusione, non ha importanza; dove andare e farsi biasimare era quasi un dovere, dice testualmente, senza vincoli né coercizioni.
La storia è là dove il centro è sempre uguale e le fughe dai personaggi hanno spesso voglia di reinventarsi o di tacere repentinamente… Davanti a queste cose arriviamo da Duchamp a Sergio Leone… A quel quotidiano che diventa un modo per capire le nostre realtà plurali: noi non siamo solo grandi cose, non siamo grandi vette, tutti noi abbiamo i nostri difetti oltre alle nostre miserie.
Questo non è il libro dell’elogio della miseria umana, è il libro di una condizione, che può esserci, riportandoci alla citazione sulla moralità filosofica, di Kant, addirittura in un lacerto intero del libro… Uno che passava per strada e la gente si aggiustava l’orologio, perché passava sempre allo stesso identico minuto… Sono queste le duplicità, anche nell’immagine di Copertina l’ombra si riflette - sempre ombre - che alla fine hanno tuttavia sfaccettature differenti e quindi storie dove il centro è sempre uguale e le fughe dai personaggi hanno spesso voglia di reinventarsi o di tacere repentinamente. E’ la silente ascesi del nulla, anche la Gaia Scienza di Nietzsche, altro autore nichilista al cento per cento, l’eterno ritorno all’eguale che è uno degli elementi fondamentali del libro. Privi di ritegni e freni tipicamente sociali, dice sempre Cannella, sono le vite parallele e il restare senza un senso in quel limbo, anche inteso, biologicamente (l’abolizione del limbo è una stupidaggine perché la teologia dovrebbe anche essere fatta d’immagini, no?) fatto di grandi costanti; anche il trascendentalismo aveva, peraltro, una sua speculare raffigurazione. Al limbo, come la verginità della Madonna, si può credere o meno, il problema non è quello. Il limbo è un luogo metaforico, è inutile abolirlo per decreto, è una dimensione, anche umana di vite, pure parallele, un mondo a parte di feconde irrazionalità per lentezza e anche per accelerazione. Eppure questo libro a volte è lentissimo, a volte accelera immediatamente. Un rapporto che si crea con gli altri ed è sempre un gioco difficile… la dama, ha un valore importante in questo libro: il gioco a dama col nonno, con gli affetti, ma anche, lo scacco rispetto alla generazione successiva: “vincevo sempre” - mi dispiaceva vincere sempre - e quindi il rapporto con gli altri, che è stato sempre un gioco difficile da giocare; lo stesso amore diventa una questione di tempo. Poi si arriva a pagina 74: Lei, lei, che è una sorta di illuminazione nel percorso, è una luce oltre la stessa ombra - dato che procura ombra la luce - che diventa autonoma, originale senza possibilità di ombre. Anche in ciò vi è l’eterno ritorno dell’eguale, anche riscoprendo quel padre che abbiamo già detto in quello specchio che poi si riguarda nel paterno sguardo e si ritrovano: costanti, affetti negati, affetti taciuti, o incapacità a volte di cogliere l’essenza e poi, nel momento supremo della morte, alla vigilia della morte, si scoprono tante cose… ed in questo specchio c’è il gioco degli scacchi. E vi è la frase che, poi, dà il senso all’intero libro: lo sguardo indifeso del figlio. Ecco, rispetto allo sguardo indifeso del figlio c’è tutto ciò che è stato prima: la Suburra.
Il riscatto dello sguardo è la potenza dell’elementare bellezza che porta a vedere un orizzonte diverso… Ed è lucido lo sguardo indifeso del figlio, è l’incanto, è la beatitudine… è una dimensione di profondità. Sabato sono andato al Teatro Politeama per la stagione sinfonica per l’amato Mahler; posso garantire che il libro di Cannella è perfettamente collimante con Mahler. Io vi invito a sentire la Prima di Mahler e di leggere insieme il libro di Cannella. Non è poco per chi è abituato come me a leggere da troppo tempo e ad ascoltare musica da altrettanto. Grazie.